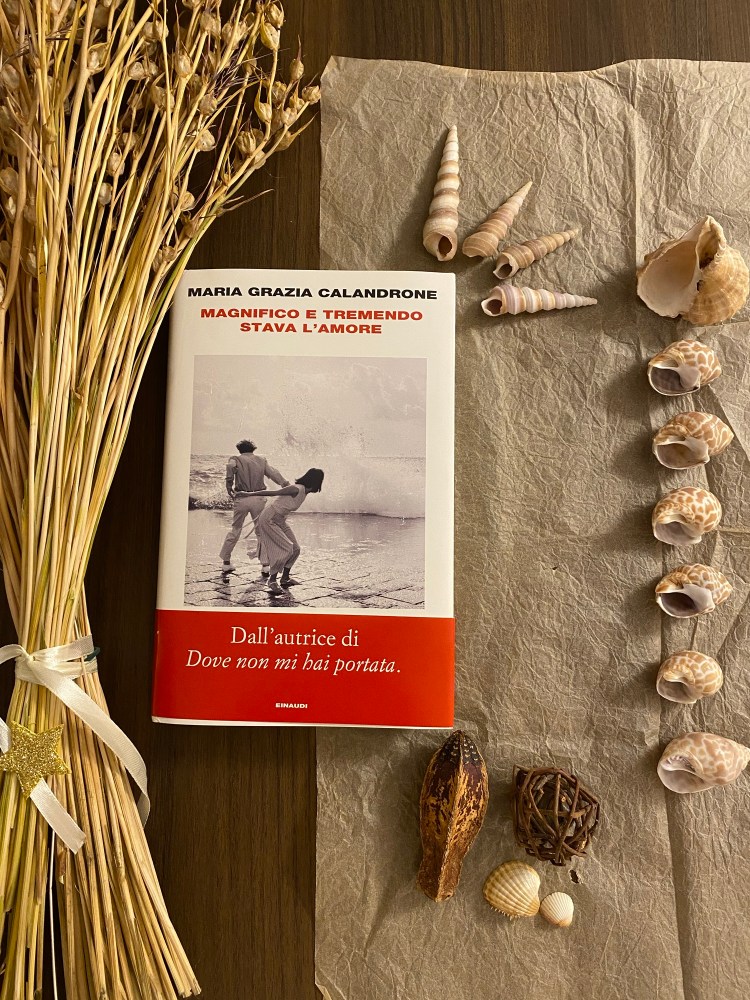
Finché succede di nuovo. Al quarto piano di via Nitti come a Catanzaro Lido. La casa piena dell’elettricità del corpo in furia. Un corpo grande, massiccio, che incute timore, che esprime il solo potere che riesce a dispiegare. Il potere fisico.
1 luglio 2024
La voragine in cui l’amore diventa morte.
Maria Grazia Calandrone torna in libreria con una storia vera, intorno alla quale costruisce, come già fece per “Dove non mi hai portata”, candidato a premio Strega 2024, un reportage minuzioso e profondo. La storia di un amore che muta in qualcos’altro di complesso, violento, distruttivo, camaleontico e incomprensibile e che diventa morte.
La morte appare in entrambi i romanzi, l’epilogo e liberazione dal dolore. Come già successe a Lucia Galante, protagonista del precedente lavoro dell’autrice, anche Luciana Cristallo si trova imprigionata dentro ad un matrimonio infelice e violento. Una gabbia dalla quale non si risolve a uscire se non all’apice della sopportazione, per amore dei figli e per quell’inspiegabile speranza che tutto finisca da sé, come per incanto. Che lui, Domenico, ritrovi la ragione, raggiunga quell’equilibrio che ha perduto insieme alle redini del suo matrimonio, che gli sfuggono di mano quando lui fallisce e lei prende in mano la loro vita per rimetterla in carreggiata.
Una storia, questa, di orgoglio ferito. Il cliché che vede il maschio soccombere quando la donna inizia a decidere per sé, per i figli, per la famiglia tutta, allo scopo d sollevarla da situazioni fallimentari. Il matrimonio, per Domenico, come un porto da raggiungere per poi salpare nuovamente verso altri luoghi. Per Luciana il coronamento del suo sogno d’amore, che naufraga immediatamente nella trascuratezza, nel tradimento, nella violenza verbale e fisica.
Negli anni ottanta la legge elargisce strumenti di difesa e di reazione per la donna oggetto di violenza. Eppure Luciana subisce. Rompe e poi si pente. Denuncia e ritira le denunce. Ha paura che le portino via i figli. La sua vita cade in picchiata in una spirale di inaudita violenza ma lei resiste. Finché un nuovo amore si affaccia. E’ questo nuovo fremito che le dà il coraggio di reagire. Di cercare un chiarimento finale. Ma l’ennesimo sopruso, l’ennesima mano che si alza diventa strumento di morte. Luciana uccide Domenico e getta il suo cadavere nel Tevere.
Un luogo, questo, che ritorna ad accogliere l’epilogo di vite schiacciate. L’acqua come elemento che lava, purifica e conclude un ciclo. L’acqua come mezzo di oblio. Di resa, di rinuncia. Soluzione estrema. Bisogno di purificare qualcosa che si è corrotto irrimediabilmente. Luciana come Lucia immerge nell’acqua la sua vita segnata dalla presenza ingombrante e egoista di un amore malato.
Maria Grazia Calandrone si insinua nella vita di queste donne segnate con umiltà, rispetto, estrema onestà. Le racconta con una sensibilità esacerbata, con partecipazione emotiva, cercando gli appigli che conducono al perdono, all’assoluzione. Mentre la sua penna ripercorre a ritroso la nostra storia recente, esse sono come ottenebrate rispetto agli accadimenti esterni, perdute, come sono, dentro al guscio della loro infelicità e dei loro conflitti. Donne che all’amore si sono consegnate totalmente, per volontà o per costrizione. L’amore come una prigionia, uno stillicidio, aghi affilati che insediano le carni alla ricerca del nervo scoperto, del sangue, della sofferenza e della rassegnazione al dolore.
La violenza è la chiave di entrambe le storie. Lucia vive la violenza come una condanna e l’adulterio come una colpa irrimediabile, che si sana solo con la morte. Per fuggire alla condanna della legge e della società tutta. In un’epoca che non sa che farsene della legge, tanto è chiusa nell’idea che la donna sia sacrificabile. Una legge che peraltro condanna la donna adultera e che non le offre alcuna via di fuga per riabilitarsi e ricominciare.
Luciana sceglie di non denunciare. Reagisce alla violenza con determinazione, creando per la sua famiglia disfunzionale una via di fuga. Tutto inutile, perché ogni sua iniziativa ferisce il suo uomo nell’orgoglio e innesca un’escalation di violenza. Luciana può contare sulla legge eppure fin da ultimo non sa abbandonarsi alla sua protezione. Fino da ultimo non sa trovare la via per amarsi e per proteggersi, incurante di tutto pur di salvare il suo matrimonio. Ma la legge del corpo è implacabile e l’istinto di sopravvivenza impera sopra ogni altro istinto.
Questo romanzo, che nasce e risorge dalle ceneri di una storia vera, è di una bellezza straziante. La prosa di Calandrone è incantevole. Un soffio di vita dentro ad un pozzo di dolore e di paura. Un racconto millimetrico, intimissimo, di una vita spezzata. Dinamiche perverse tristemente note anche oggi, che di femminicidio si continua a morire, L’inefficacia dell’impianto legislativo a protezione della donna, che viaggia con uno scarto temporale troppo grande rispetto alle esigenze dell’oggi. Che giunge a soluzioni tutelanti solo dopo che il sangue è sgorgato, copioso e infiltrante.
Luciana, come già Lucia, è nutrita, curata e assolta dalla penna dell’autrice, che giunge leggerissima a sondare i suoi pensieri, le sue sensazioni. A renderle giustizia, a far conoscere a tutti la sua storia, a pretendere comprensione, condivisione, compassione. La sovrapposizione con la sua storia è totale. E anche Domenico beneficia dello stesso trattamento misericordioso. Posto sotto una lente di ingrandimento, allo scopo di penetrare la genesi delle sue aberrazioni.
Come si esce dalla lettura di questo romanzo-reportage? Sicuramente provati. Arrabbiati, frustrati. Ma anche increduli, disarmati di fronte a tanta inutile violenza. Con la voglia di accogliere, curare, guarire. Dispensare una seconda occasione, ricercare una fonte di felicità per Luciana, che pure le legge ha assolto. Ma l’assoluzione non è mai sufficiente, da sola, a guarire. Resta la colpa, la consapevolezza di aver ucciso e la rabbia per una morte che si poteva evitare. Ma ciò che accade dopo l’ultimo irrevocabile atto è sempre superfluo e inutile.
Ma il “prima che sia troppo tardi” è troppo spesso secondario rispetto alla storia e alle sue propaggini velenose. E Lucia, e Luciana sono morte, ognuna a suo modo e niente potrà riportarle indietro, quando tutto ancora si poteva salvare.
La storia della violenza di genere, del femminicidio, del resto, è una storia che guarda sempre indietro. Che implode quando ormai niente può essere salvato.
Forse è proprio questa irrevocabilità ad acuire la sensibilità di Maria Grazia Calandrone, a esacerbare il suo bisogno di raccontare, scandagliare, straziare. Di scarnificare l’amore fino a tirarne fuori quella sua anima misconosciuta e incomprensibile. Quella tenerezza che scardina ogni regola. Quel bisogno di possedere l’altro che implode su se stesso. Quel desiderio di essere amati più di ogni altra cosa al mondo. Di essere tutto per l’altro. Di essere il confine e l’ orizzonte che corre a perdita d’occhio. La lama e il balsamo. La cura e il cancro corrosivo e letale. La porta che di sera chiude il mondo fuori, E dentro, il calore, il cuscino morbido, il profumo di pane e di latte. Un microcosmo precluso agli altri, paradiso o galera. In cui si vive o si muore. Nessuna separazione, neanche quando ormai la legge lo consente. L’epilogo, qui si scrive con il sangue e con il sangue si lava il peccato e il peccatore.
Il romanzo
Tutti gli amanti giurano che il loro amore è diverso da quello degli altri. Specie all’inizio, quando la risacca della vita non ha ancora intaccato il sentimento. Poi le cose cambiano, e le storie tendono a somigliarsi. Ma non questa. L’amore raccontato in queste pagine – tratto da una vicenda di cronaca nera – ha avuto un finale sorprendente, che solo la realtà e una sua misteriosa giustizia potevano immaginare. Del resto «il destino, quando si accanisce, mostra pure una certa fantasia».
«Magnifico e tremendo stava l’amore rielabora un caso di cronaca nera. Il 27 gennaio 2004, dopo circa vent’anni di violenza subita, Luciana uccide con dodici coltellate l’ex marito Domenico e, insieme al nuovo compagno, ne getta il corpo nel fiume Tevere. Il 24 giugno 1965 mia madre Lucia, dopo anni di violenza subita da parte del marito, getta sé stessa nel fiume Tevere, insieme al suo nuovo compagno, mio padre. Perché in quegli anni non esiste la legge sul divorzio. Il motivo della mia ossessione è fin troppo evidente. Ma la vicenda giudiziaria di Luciana si conclude con un provvedimento destinato a fare giurisprudenza. Mi è parso allora utile, anzi necessario, rintracciare negli atti processuali le motivazioni umane e legali di una sentenza tanto d’avanguardia. L’analisi della storia e dei suoi esiti ha finito per generare un libro che ha sorpreso per prima chi l’ha scritto, essendo diventata un’opera scorretta, che non assume esclusivamente il punto di vista della vittima, si chiede anzi chi dei due sia la vittima, quale patto leghi i protagonisti e in quale oscurità delle persone quel patto abbia radicato. Chi scrive, insomma, ha cercato di comprendere profondamente le ragioni della violenza. E forse, chissà, ha lavorato proprio per emanciparsi da uno sguardo semplice sulla violenza. Non c’è dunque condanna, ma esposizione, quando possibile poetica, di quel magnifico e tremendo amore».
L’autrice
Maria Grazia Calandrone è poetessa e scrittrice. Collabora con la Rai come conduttrice e autrice. Con i suoi libri di poesia ha vinto importanti premi. Tra i suoi libri in prosa, Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021, entrato nella dozzina del Premio Strega) e Dove non mi hai portata (Einaudi 2022, nella cinquina del Premio Strega e vincitore del Premio Vittorini, Premio Sila, Premio Pozzale Luigi Russo, Premio giuria popolare Clara Sereni e Premio giuria popolare Asti d’Appello). Per Einaudi ha pubblicato anche Magnifico e tremendo stava l’amore (2024).
- Casa Editrice: Einaudi Editore
- Pagine: 328
- Prezzo: E 20,00





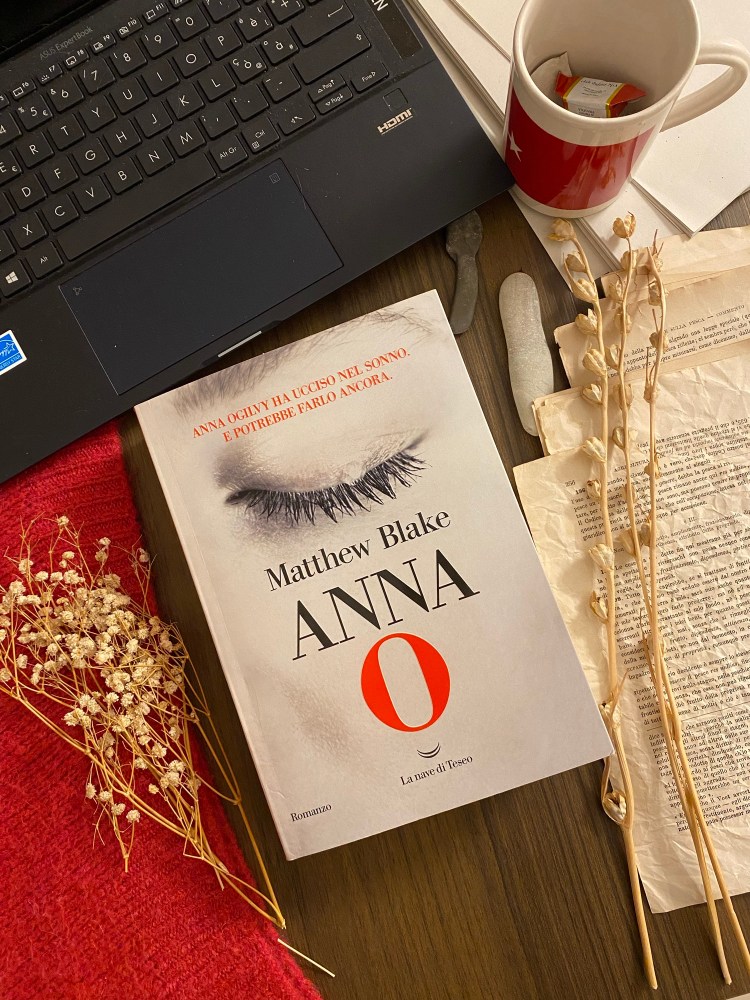



Devi effettuare l'accesso per postare un commento.