Il futuro che guarda il presente

Ian McEwan immagina un futuro che racconta il nostro presente: memoria, social e verità in Quello che possiamo sapere.
Quello che possiamo sapere di Ian McEwan è un romanzo che guarda il presente come se fosse già passato, e proprio per questo riesce a raccontarlo con una lucidità inquietante. Ambientato in un futuro prossimo, il libro costruisce una distanza temporale che permette di osservare il nostro oggi come un reperto: fragile, contraddittorio, già esposto al giudizio di chi verrà dopo. McEwan sceglie una prospettiva narrativa insolita e profondamente letteraria per interrogare la memoria, la verità e il modo in cui la storia del nostro tempo verrà conosciuta e interpretata.
Fin dalle prime pagine, il romanzo mette in scena una tensione costante tra ciò che crediamo di sapere e ciò che effettivamente resta. Una guerra silenziosa tra vero e falso, tra probabilità e aspettative, tra documenti e narrazioni. Una riflessione che coinvolge il futuro dell’umanità, il collasso ambientale, il ruolo dei social e l’illusione che l’accumulo di dati possa coincidere con la conoscenza.
Raccontare il presente come se fosse passato
Scrivere un romanzo ambientato in un futuro prossimo e parlare di un passato che, agli atti pratici, è il presente, è una scelta romantica. Un romanzo abitato dai riverberi della nostalgia di qualcosa che non si è conosciuto, ma che viene immaginato come migliore. Nonostante il ricordo delle catastrofi ambientali che hanno mutato profondamente il mondo, la sua conformazione, e l’uomo che vi abita, disorientato da nuovi confini, nuove forme ed altrettanto nuove idee di segregazione e di solitudine. Nonostante le difficoltà di adattare l’idea al ricordo, la sensazione al vissuto vero. E di mantenere un interesse vivo verso il passato, che di per sé appare più facilmente un sacco vuoto, un luogo ormai arido, irraggiungibile e per questo trascurabile. Guardare il passato dall’alto, da una finestra aperta sul tempo, suona come un invito a riconsiderare il nostro presente, a proteggerlo, a dargli il valore che merita e che solo a posteriori, generalmente, viene percepito per quello che era, cioè una assoluta ricchezza.
Questo anelito per qualcosa che non si è conosciuto e che è andato perso meriterebbe una parola tutta sua, perché va al di là della nostagia, è la smania per qualcosa che un tempo era noto. Non proprio un tormento, ma nemmeno una risorsa. Quel misto di piacere e pena è emotivamente devastante, impedisce la concentrazione.
Nostalgia e distacco: guardare il nostro tempo da lontano
Ian McEwan, con la sua penna assolutamente perfetta, guarda l’oggi da lontano imponendosi quel distacco che dovrebbe rendere l’occhio più obiettivo. L’uomo ha bisogno di distanza, di memoria, per riabilitare qualcosa che sembrava corrotto, inappropriato e incurabile. E ciò che costruisce appare un piccolo miracolo e qualcosa di assolutamente mai visto. Basta andare avanti di cento anni per scoprire la terra spazzata via dalle acque e l’uomo inselvatichito, preda di nuove dipendenze, di vincoli che adesso, dopo le inondazioni e i disastri ambientali, sembra accettare con rassegnazione sorda, instupidito, quasi, dagli abbagli di un’epoca ormai trascorsa che non potrà più tornare. Una involuzione che sembra dettata dalla ribellione della natura contro gli abusi della specie umana. Un ripiegarsi su se stesso, l’occhio a scrutare e la mente a rivangare ciò che è stato, in un mondo più grande, più esteso, seppure sull’orlo di un precipizio, causato dall’influenza incontrollata dei social e dai sussulti di un ecosistema al collasso.
La nostalgia, l’indulgenza, lo stupore attraversano il lettore, mentre legge di un futuro che mostra i segni del degrado, della perdita, della non conoscenza. Un mondo che appare geograficamente più grande a causa delle difficoltà dei trasporti in un ambiente governato dalle acque, ma significativamente più piccolo, perduto nel ricordo, in un presente in cui l’impronta del disastro deve ancora essere metabolizzata. E’ da quel presente limaccioso e rassegnato che Thomas Metcalfe, studioso di letteratura del periodo 1990 – 2030, si muove, intrecciando la ricerca di un vecchio poemetto risalente al 2014 con le sua vita personale.
Thomas Metcalfe e l’ossessione per la memoria perduta
Il romanzo si muove sugli esiti di questa ricerca. L’oggetto è un componimento poetico a corona, quindici sonetti ognuno dei quali inizia con la strofa con cui finisce il precedente, scritto nel 2014 dall’eminente poeta Francis Blundy per la moglie Vivien. Una sola copia, decantata dal poeta stesso la sera del compleanno di Vivien, mai pubblicata ed evidentemente andata perduta. Come tutto ciò che è introvabile, la Corona per Vivien scatena nel mondo accademico e in molti altri ambienti una sorta di febbre. Quel tipo di passione ardente che si prova per ciò che non si potrà avere. Metcalfe vive una specie di ossessione per quell’opera dal gusto barocco e con essa anche per il periodo in cui viene alla luce. Un’epoca complessa, in cui le trasformazioni tecnologiche investono l’uomo e lo pongono innanzi a cambiamenti veloci, destabilizzanti ma anche forieri di un’euforia difficilmente imbrigliabile. Una miccia capace di innescare più tipi di incendi, tutti pericolosi per la specie e per il pianeta. Produzione incontrollata, governata dai magnati dell’energia fossile, grandi gruppi industriali che credono solo nel denaro, speculazione, guerre atomiche come spauracchio di poteri che inseguono ricchezze con un occhio miope e egoista. E poi disastri ambientali come dirette conseguenze. Intelligenza artificiale e social totalmente fuori controllo, capaci di dissacrare qualsiasi credo e qualsiasi reputazione, anche la più immacolata. Il sapere minacciato da un manipolo di persone senza cultura, a capo chino sopra una tastiera e davanti ad uno schermo.
Il nostro presente come passato affascinante
Il nostro presente diventa un passato che resta ugualmente affascinante, seppure stretto nelle morse di un’accelerazione che lo distorce e lo snatura. L’aria ancora non del tutto incontaminata, l’acqua brillante, la terraferma che si estende sotto i piedi. Erba, alberi, fiori. Una varietà di specie ormai perdute, risorse disponibili, una vita lunga, piena, sfacciatamente aperta ad ogni piacere. McEwan riesce così ad emozionarci e a palesare la bellezza di cui ancora disponiamo, pur mettendoci in guardia dai pericoli e da ciò che potrebbe accadere. All’ecosistema, alla politica, alla gestione delle risorse, alla pace stessa, oggi minacciata da più parti.
Ecco, questo è il sentimento che sto cercando di descrivere. La figura in attesa sul ponte moderno sono io. Il ponte crollato sul fiume e l’uomo che cent’anni prima lo attraversa rappresentano il passato dal quale anch’io sono escluso, il passato che da qui sembra integro e prezioso, il tempo in cui molti problemi dell’umanità potevano ancora essere risolti. Quando troppo pochi comprendevano la sublime bellezza dei loro mondi, naturali e costruiti dall’uomo.
Nel 2119 MetCalfe è deciso a scoprire la verità sul poemetto perduto. Una ricerca disperata in un mondo che ha perso interesse per il passato. Persino i suoi corsi accademici non destano interesse negli studenti, presi più dai dettagli delle vite passate che non dalla storia nel suo complesso. Il suo rapporto con la compagna è in crisi come lo è tutta la sua vita, una missione anacronistica, una battaglia persa in un presente sempre più miope e preso da se stesso.
Cosa resterà di noi
La storia recente ha lasciato tracce ben visibili. Nei primi anni 2000 si fa già uso della posta elettronica, i telefoni stanno mutando in dispositivi che fotografano, che utilizzano il messaggio di testo, che navigano su Internet. I social si stanno affacciando e si apprestano a racchiudere veri e propri microcosmi di informazioni. Eppure della Corona nessuna traccia. Metcalfe ha avuto accesso a una miriade di informazioni su Blundy e su Vivien e sui loro conoscenti ed amici ma niente sembra portarlo al poemetto. Eppure nella storia arriva una svolta e la sua portata sarà enorme. Tutti i costrutti di Metcalfe cadranno, mostrando una volta per tutte che niente è mai del tutto sovrapponibile a ciò che ci immaginiamo e all’idea che ci eravamo fatti di persone ed eventi.
La fallacia del sapere e delle deduzioni storiche
Il romanzo racchiude molte verità e molte lezioni. Una fra tutte la fallacia dei nostri ragionamenti e delle nostre deduzioni, quando cerchiamo di comprendere chi ci ha preceduti. E anche i preconcetti che minano le nostre conoscenze, le conseguenze errate che traiamo dai comportamenti degli uomini e delle donne del passato. La convinzione di sapere, di dedurre, la fede sconfinata nella logica, nella consuetudine, nell’effetto scatenato da una causa che siamo convinti di penetrare a fondo.
Il tema di ciò che traiamo dai fatti e dai ricordi del passato e di ciò che lasceremo ai posteri è trattato con enorme trasporto emotivo. Una pietà che corre lungo tutte le pagine. La compassione per l’uomo e per i suoi limiti. Il perdono precostituito verso i suoi errori, la possibilità di immaginare un futuro verosimilmente catastrofico ma in cui non tutto è perduto. Ed infine l’enorme fiducia nell’uomo e in tutte le specie, dotate di una provvidenziale onniscienza e della capacità di prevedere gli eventi, evitando il peggio. Chi ci seguirà sulla linea del tempo cosa potrà sapere di noi? Quali notizie lasceremo, quali ricordi, dalle bacheche dei nostri social, dai nostri messaggi senza punteggiatura, dalle foto modificate, dai nostri tentativi di sembrare interessanti? La storia futura dovrà orientarsi in questo rumore. Dovrà distinguere tra ciò che è stato vissuto e ciò che è stato messo in scena. Tra emozione autentica e costruzione narrativa.
Memoria e racconto: il vero antagonista del romanzo
Infine la memoria, questa spugna che assorbe tutto e che sa anche trasformarlo in ciò che più fa comodo, distorcendo il significato primario a vantaggio del nostro ego, diventa in Quello che possiamo sapere l’antagonista del racconto, della parola scritta. Ciò che resta non è solo ciò che è accaduto, ma ciò che è stato raccontato con maggiore forza, maggiore visibilità, maggiore capacità di circolazione. Quello che possiamo sapere dialoga con questa inquietudine. Ricorda che la conoscenza richiede tempo, selezione, responsabilità. Che ogni archivio ha bisogno di uno sguardo etico. Che la memoria, senza pensiero, resta materia grezza.
Forse la storia del nostro tempo, ricostruita attraverso i social, apparirà confusa, contraddittoria, eccessiva. Un archivio smisurato di immagini, opinioni e identità performate. Quello che possiamo sapere di Ian McEwan ci ricorda che il senso non coincide con la quantità, e che la memoria ha bisogno di pensiero per diventare conoscenza. In un mondo che registra tutto, la letteratura resta il luogo in cui il tempo viene compreso, non solo conservato. E oggi, più che mai, questo fa la differenza.
Perché leggere “Quello che possiamo sapere” di Ian McEwan
Leggere oggi Quello che possiamo sapere di Ian McEwan significa interrogarsi su come il nostro tempo verrà ricordato. Non come lo raccontiamo, ma come resterà. Il romanzo mette in crisi l’idea che conservare tutto equivalga a comprendere, e mostra quanto la memoria, senza uno sguardo etico e interpretativo, possa trasformarsi in una distorsione.
McEwan costruisce una storia che parla di archivi, di social, di conoscenza e di perdita, ma soprattutto parla di responsabilità. Di ciò che lasciamo dietro di noi mentre viviamo immersi nel presente. In un’epoca che registra tutto e riflette poco, questo romanzo invita a rallentare, a selezionare, a pensare.
Quello che possiamo sapere si legge per comprendere che la verità non nasce dall’accumulo, ma dall’interpretazione. E che la letteratura resta uno degli ultimi strumenti capaci di dare forma umana al caos della memoria contemporanea.
Il romanzo
Nell’ottobre del 2014, durante una cena tra amici, il grande poeta Francis Blundy dedica alla moglie Vivien un poema che non verrà mai pubblicato e di cui si perderanno le tracce. Un secolo più tardi, in un mondo ormai in gran parte sommerso dopo un Grande Disastro, lo studioso di letteratura Thomas Metcalfe scopre degli indizi che puntano a un intreccio amoroso e criminale. Ma che ne sappiamo degli uomini e delle donne del passato, con le loro passioni e i loro segreti? E che sapranno i nostri discendenti di noi e del mondo guasto che gli lasceremo in eredità? Nel maggio del 2119 Thomas Metcalfe, studioso di letteratura del periodo 1990-2030, si reca per l’ennesima volta alla biblioteca Bodleiana per consultarne gli archivi, a lui arcinoti, nel tentativo di scovare qualche scampolo di informazione inedita sull’oggetto dei suoi interessi, la fantomatica “Corona per Vivien” del grande poeta Francis Blundy, mai ritrovata. Il viaggio è disagevole, ora che la Bodleiana è stata trasferita nella Snowdonia, nel Nord del Galles, per sottrarre il suo prezioso contenuto alle acque che, dopo il Grande Disastro e l’Inondazione che ne seguì, sommersero l’originaria sede, a Oxford, e gran parte della terra. Ma gli abitanti del ventiduesimo secolo, sopravvissuti a quella catena di eventi, sono avvezzi al disagio e alla penuria, e inclini a guardare alla ricchezza e alla varietà del mondo precedente ora con rabbia ora con sognante nostalgia. Forse anche così si spiega l’ossessione di Metcalfe per il poemetto perduto. Miracolo di costruzione poetica, la Corona di Blundy fu composta poco più di cent’anni prima, nel 2014, in occasione del compleanno della moglie Vivien, e recitata un’unica volta durante i festeggiamenti presso il Casale dei Blundy, in un tripudio di vini e cibi deliziosi e ora introvabili, alla presenza della loro cerchia di amici. Facendo riferimento al celebre banchetto del 1817, cui parteciparono Keats e Wordsworth, l’evento fu successivamente definito «Secondo Immortal Convivio». La profusione di diari, corrispondenze e messaggi disponibili racconta delle correnti di amore e invidia che attraversavano tutti i partecipanti, del primo marito di Vivien, il liutaio Percy, e della malattia degenerativa che si era impossessata del suo cervello, delle ambizioni represse della donna. Ma dell’agognata “Corona per Vivien” neanche l’ombra. Che fine ha fatto la sublime poesia della cui stessa esistenza ormai i più dubitano? Quale verità si cela dietro la sua scomparsa? E quale differenza potrebbe mai fare il suo ritrovamento? Sarà un’intuizione geniale a fornire l’indizio che orienterà Metcalfe in una caccia al tesoro stevensoniana nell’ignoto. Il suo viaggio svelerà una storia d’amore e di compromessi e un crimine impunito, e getterà una luce nuova su figure che le parole tramandate gli avevano fatto credere di conoscere intimamente.
L’autore
Scrittore e sceneggiatore britannico. Esordisce con due raccolte di novelle, Primo amore, ultimi riti (1975 – pubblicato da Einaudi nel 1979 con la traduzione di Stefania Bertola) e Tra le lenzuola (1978 – edito da Einaudi nel 1982 sempre con la traduzione della Bertola), che ritraggono, in uno stile raffinato e impersonale, situazioni quotidiane, dominate tuttavia dall’ossessione per il sesso e segnate dalla morte. Sesso, perversione e morte sono temi trattati anche nei primi romanzi, Il giardino di cemento (1978, portato sul grande schermo nel 1993 dal regista Andrew Birkin con la nipote Charlotte Gainsbourg e tradotto dalla Bertola per Einaudi nel 1980) e Cortesie per gli ospiti (The Comfort of Strangers 1981 – Einaudi 1983, tradotto in film nel 1991 dal regista Paul Schrader con Christopher Walken, Rupert Everett, Natasha Richardson ed Helen Mirren), e diventano una metafora del vuoto di valori del mondo contemporaneo. Nei romanzi successivi lo scrittore si interroga sulla natura delle relazioni e dei sentimenti, spesso estremi, nati in contesti esasperati. Bambini nel tempo (1988 – Einaudi traduzione di Susanna Basso): la scrittura nervosa e asciutta di McEwan si apre in questo testo a improvvisi lampi di suggestiva liricità. Lettera a Berlino (1990 – Einaudi, anocra tradotto da Susanna Basso), da cui John Schlesinger trasse nel 1993 il film The Innocent, con Anthony Hopkins e Isabella Rossellini. Del 1993 anche la storia di The Good Son di Joseph Ruben con Macaulay Culkin, Elijah Wood. Cani neri (1992) indaga invece l’impossibilità di conciliare religione e progresso scientifico, materialismo e metafisica. Si ricordano poi L’amore fatale (1997, Enduring Love) da cui l’omonimo film del 2004 di Roger Michell con Daniel Craig, Amsterdam (1998, Booker Prize), Espiazione (2001 Atonement – nel 2007 divenuto un film di Joe Wright con James McAvoy e Keira Knightley), Sabato (2005), Chesil Beach (2007 a breve un film con la regia di Sam Mendes e la sceneggiatura dello stesso McEwan). Del 2011 è Solar. Nel 2012 esce Miele. Alla sua produzione appartengono anche le raccolte di storie per bambini Rose Blanche (1985) e L’inventore dei sogni (1994). McEwan ha scritto anche per la televisione. Nel 2017 ha vinto il Premio Bottari Lattes Grinzane per la sezione La Quercia, intitolato a Mario Lattes (editore, pittore, scrittore, scomparso nel 2001), dedicato a un autore internazionale che ha saputo raccogliere nel corso del tempo condivisi apprezzamenti di critica e di pubblico.
Tra le sue recenti pubblicazioni ricordiamo: Nel guscio (2017), il racconto Il mio romanzo viola profumato (2018),Macchine come me (2019), Lo scarafaggio (2020), Lezioni (2023), Quello che possiamo sapere (2025).
- Casa Editrice: Einaudi Editore
- Traduzione: Susanna Basso
- Pagine: 376
- Prezzo: E 21,00






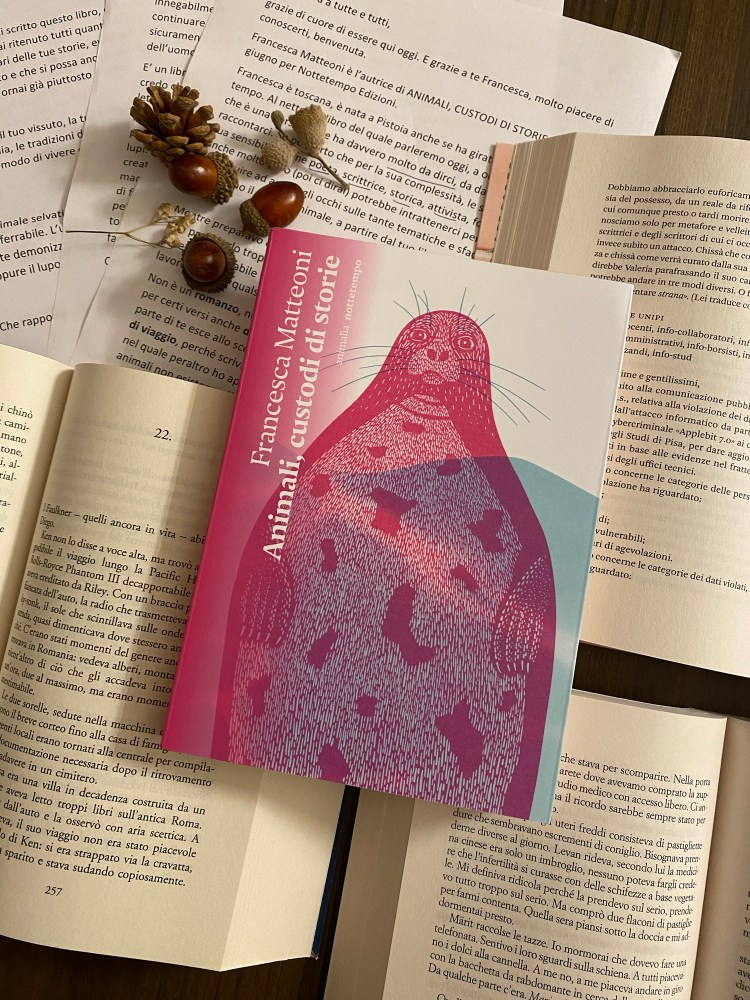

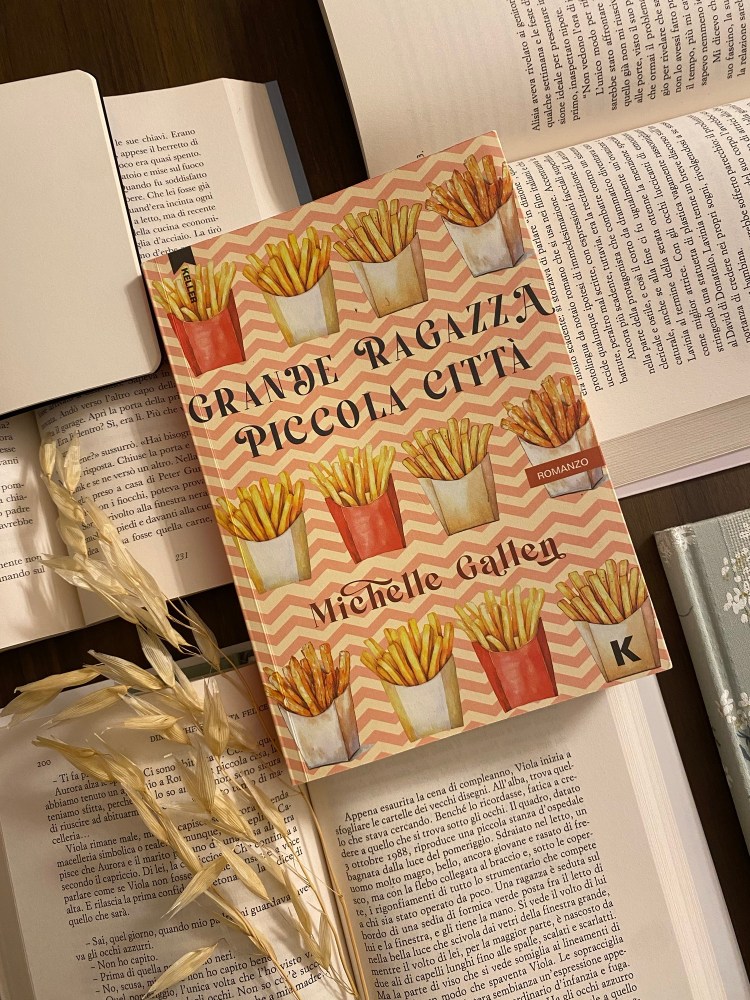
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.