
L’essere oggetto di dimenticanza – stavolta non come responsabile ma come vittima – l’aveva confortato del fatto che l’amnesia improvvisa ha l’essenza e la pervasività del tragico: l’inaspettato vuoto di memoria che coglie l’attore prima di una battuta pronunciata alla perfezione migliaia di volte, quel buco, quello strappo nella tela della rappresentazione, svela l’artificiosità disarmata e disarmante della recita umana. Dimenticare, aveva pensato l’ex ingegnere, è naturale come l’entropia, o come l’acqua di un fiume che finisce nel mare.
E’ quasi sempre troppo tardi. Una storia familiare non convenzionale.
26 ottobre 2025
Cosa accade quando cerchiamo di ingannare la colpa, distrarla per ricominciare tutto da capo?
Quella che ci racconta Fabio Massimo Franceschelli è una famiglia come tante, probabilmente più colta della media, tuttavia vittima del disorientamento generale che ha colto questa vacillante istituzione negli ultimi decenni. Gli eventi, il tempo, le variabili della vita la colpiscono in pieno petto mentre il padre, il patriarca ormai destituito e scialbo, era occupato a costruire carriere e parabole esistenziali. Con lui uomini e donne senza macchie, punti fermi impegnati a dimostrare che si può fare tutto e al meglio e contemporaneamente, con soddisfazione e lucro.
Di fatto l’aberrazione è più ampia, maggiormente e universalmente impattante: non è un errore del singolo, che qui e altrove assolviamo con formula piena, E’ un errore di tempo. Di un’epoca, pochi decenni in realtà, in cui tutto si è accelerato al massimo e tutti hanno dovuto anteporre il lavoro a qualsiasi altra cosa. Ognuno di noi sa di cosa si tratta. Abbiamo fatto parte di questo ingranaggio perverso, abbiamo provato ad addomesticarlo, a vestirci dei panni di supereroi confidando sull’eternità e inossidabilità della nostra salute mentale. Poi abbiamo fatto marcia indietro. Siamo andati negli studi dei terapeuti, abbiamo confessato la nostra vanagloria tossica nei confessionali, abbiamo rotto matrimoni, dato le dimissioni. Abbiamo fatto coming out. Lasciato le città, il partner, le brutte abitudini, i chili di troppo, i balconcini asfittici e gli animali domestici frustrati e spelacchiati, alla ricerca dell’autenticità. Della vita vera, del brivido dell’imprevisto, l’urlo agghiacciante della natura, l’attimo prima che si ribelli e che scateni la sua energia su di noi.
Questa specie di rivelazione tardiva coglie in pieno petto anche Carlo Castelli, un uomo in là con gli anni, ex giornalista di guerra. L’uomo che ha fatto della morte l’estremo spettacolo. Che di morte si è nutrito fino alla nausea e che adesso desidera cambiare tutto. Mettere se stesso al centro, la natura degli appennini ai margini e la sua trascuratissima famiglia a fare da paravento ai sensi di colpa, ormai acuti, egoisti, pretenziosi. Isolarsi, prendere tempo per riflettere, scrivere un romanzo che riassuma la sua vita e ciò che ha appreso vivendola. Intorno a sé i figli, che non ha mai frequentato, né mai sopportato, in tutta onestà. Carlo ha preferito gli afrori della guerra, il luccichio del sangue ai pomeriggi con loro, creature misconosciute e in qualche modo spaventose. Ma adesso, mentre la sua vita probabilmente volge al termine, ha la pretesa di averli tutti intorno a sé, compresa la compagna che odia la montagna e il suo essere inafferrabile, remota e irreale.
I figli di Carlo non hanno avuto una vita migliore della sua. Hanno sofferto la mancanza, l’assenza fino a trasformare la nostalgia in una forma di odio silente. Essi hanno visto da vicino gli effetti devastanti dell’individualismo degli anni di fine secolo scorso. Oggi sono uomini incompleti e fragili. Sandro ha dimenticato il proprio figlio in auto e da allora è avvinto agli psicofarmaci e all’alcol. Stefano è un piccolo squalo che cerca di stare a galla senza prendere una posizione precisa: il suo partito non sta a destra né a sinistra e si alimenta di proclami deboli quanto il proprio leader.
Lo scontro generazionale è inevitabile e i tentativi di Carlo di riunificare la sua famiglia sono patetici e fallimentari. Intorno a loro il paesaggio appenninico, foriero di atmosfere mistiche, di immagini fugaci come ectoplasmi, popolato di animali che sembrano possedere un sesto senso, che utilizzano per spaventare, indirizzare e avvertire gli umani che incontrano. La grande casa in montagna è il catalizzatore di ogni energia, di tutte le vibrazioni. E’ essa stessa un organismo vivente che accoglie tutti dentro al proprio ventre carnivoro e pulsante. Un po’ respingente, un po’ oracolo di un’esistenza che cerca assoluzione ma trova la pena, la contravvenzione.
Se per Carlo scrivere è una preparazione alla morte, un modo per distaccarsi dalla vita prendendone merito e perdono, per i figli l’incursione dentro la casa-madre è spesso motivo di rabbia, di rancore. Ne traiamo la convinzione che avvedersi tardivamente dei propri errori quasi mai dispensa dalla punizione e quasi mai aggiusta un’assenza. Ma anche che la ricerca del perdono, il ripensamento, il così-detto resoconto della propria esistenza è probabilmente un’esigenza più personale che risolutiva. L’estremo egoismo che contraddistingue l’uomo si palesa senza veli e tratteggia un’immagine poco lusinghiera dell’animale umano, poco disposto a sacrificarsi per un bene comune.
Ed ecco che Introduzione alla mia morte diventa il requiem di un’epoca in cui edonismo e individualismo estremo hanno fatto danni irreparabili creando mostri e mostriciattoli, le cui propaggini hanno stretto in una morsa i nostri figli, condannandoli all’invisibilità.
Ma questo romanzo è anche un inno alla forza e all’imperturbabilità dell’uomo che, sebbene abbracciato dalla colpa, desidera giustificarsi mostrando tardivamente la propria coscienza, il proprio buon cuore. La raggiunta consapevolezza di aver commesso degli errori ma proprio per questo pretenderne l’assoluzione, reclamando il diritto ad una discendenza onnisciente, imperturbabile, perfetta.
In quello che si mostra un romanzo illuminato, rabbioso e malinconico, Franceschelli orchestra una prosa che abbacina e abbraccia il lettore. Bella, ritmata, rotonda, esteticamente e semanticamente perfetta. Poetica a tratti ma anche cruda e visionaria, vittima della fascinazione di una natura rigogliosa, ridondante, magica e spaventosa.
Franceschelli tratteggia uomini e donne del nostro tempo con grande profondità e rara sensibilità, toccando temi che sono tabù scottanti e inenarrabili. E ammaestrando il cinismo che pervade il nostro tempo, nel quale è preferibile attaccare che essere attaccati. Mentire per non scoprirsi. Allontanarsi per non farsi prendere dall’amore, che indebolisce e offusca. Uccidere per non morire.
Il romanzo
Un uomo che dimentica in auto il suo bambino; un politico populista e vanesio che fonda un nuovo partito; un giornalista, famoso inviato di guerra, che si trasferisce in un’isolata casa in montagna e cerca di recuperare e sintetizzare il senso della sua vita nella scrittura di un romanzo e nella ricomposizione attorno a sé di una famiglia da sempre trascurata. Infine Sonia, la donna che è bussola e cifrario nel ripercorrere le vite di questi uomini autocentrati e che raccontano, loro malgrado, la storia della società di cui sono al tempo stesso prodotti e fautori. Quattro personaggi che compongono una famiglia che di tradizionale non ha nulla. Quattro voci che invitano il lettore ad indagare nelle storie che raccontano, a destreggiarsi tra apparenze farsesche e un’interiorità buia e respingente per giungere a delineare il ritratto della nostra società. Franceschelli, con il suo linguaggio ammaliante, un’ironia sottile e la sapiente costruzione della narrazione, dà vita a un romanzo che con la potenza visionaria di un dramma in più atti è capace di inchiodare il lettore, non solo alla storia narrata, ma anche e soprattutto alla rappresentazione di una realtà da cui si tende a volgere lo sguardo.
L’autore
Fabio Massimo Franceschelli
Ecletticamente ha toccato vari generi letterari: dalla saggistica alla drammaturgia, alla critica e, ora, alla narrativa. Laureato in Storia delle religioni, ha pubblicato saggi e articoli sui moderni sincretismi religiosi, con particolare attenzione ai culti afrobrasiliani. Per il teatro è autore di drammi, monologhi e commedie rappresentate in Italia e all’estero, oltre che regista e direttore di festival teatrali. È redattore della rivista di drammaturgia contemporanea Per la scena. Il romanzo Italia, finalista alla XXVIII edizione del PREMIO CALVINO, è il suo esordio in narrativa.
- Casa Editrice: Del Vecchio Editore
- Pagine: 234
- Prezzo: E 19,00
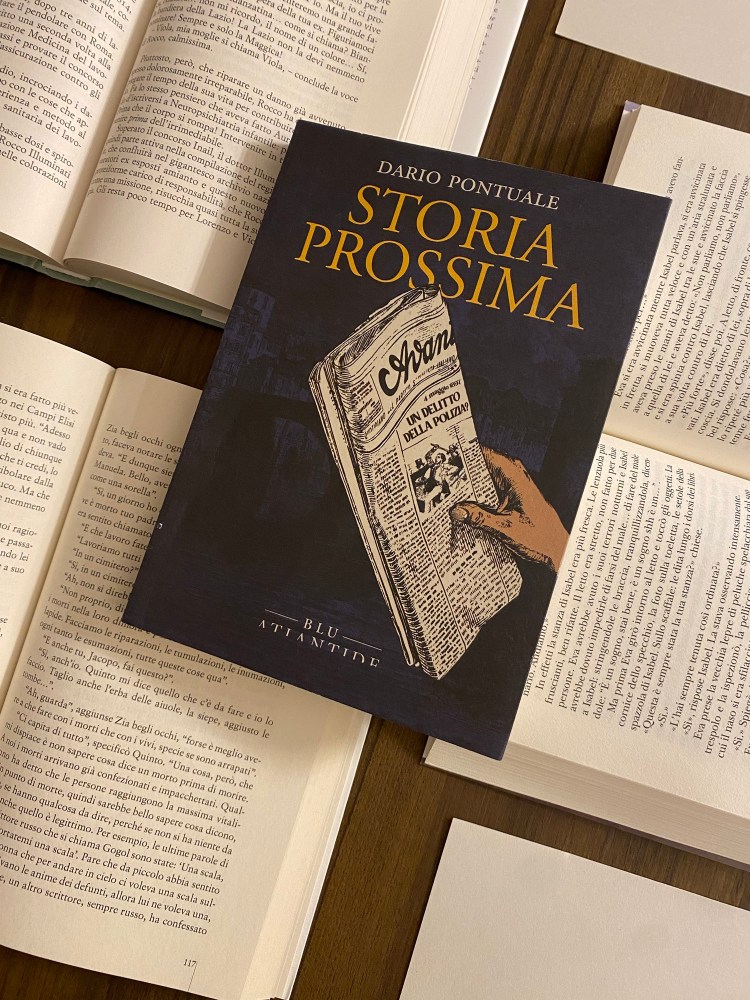









Devi effettuare l'accesso per postare un commento.